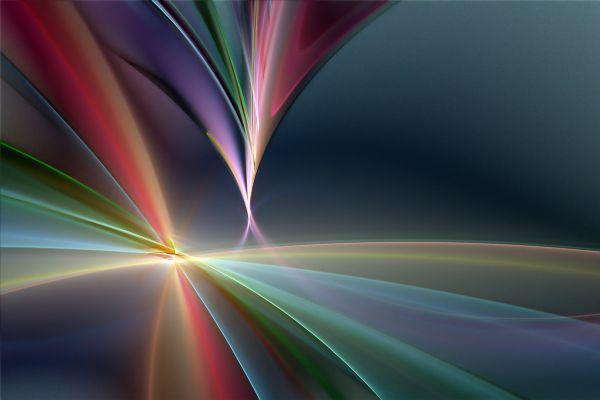Video Stream
Disfunzioni del pavimento pelvico: obiettivi e modalità della riabilitazione
Il pavimento pelvico è l’insieme di muscoli e tessuto connettivale che chiude in basso la cavità pelvica e che sostiene, nella donna, la vagina, l’utero, la vescica e il retto. La riabilitazione uroginecologica si pone come alternativa alle tradizionali terapie farmacologiche e chirurgiche...