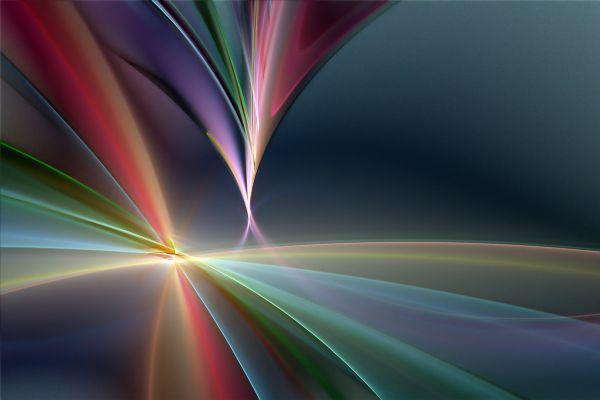Le vostre domande
Dopo un cancro al seno: come curare i sintomi urinari della menopausa
Dieci anni fa sono stata operata di tumore al seno. Dopo l’intervento ho assunto gli inibitori dell’aromatasi e il tamoxifene, con risultati che i medici definiscono ottimi. Però nel corso del tempo ho iniziato a soffrire di incontinenza da urgenza e nocturia...